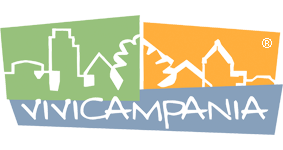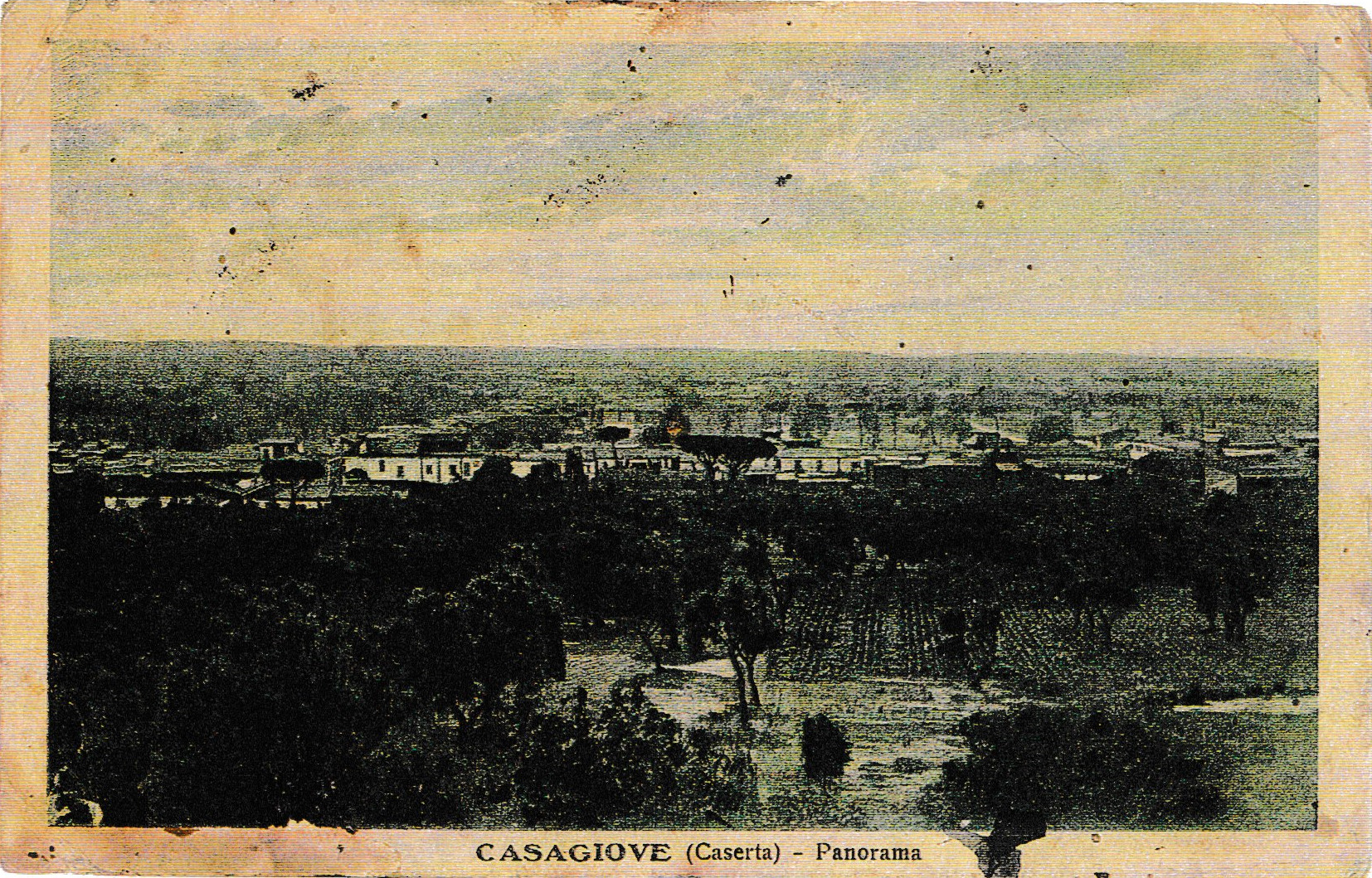
Gli “emarginati individui” di Casanova (Casagiove). Tre uomini accusati di brigantaggio postunitario
Premessa
Secondo quanto affermato da Olindo Isernia in una sua pubblicazione divulgata nel 2011 in pochissime copie, dal titolo: “Per una lettura ravvicinata del brigantaggio postunitario in Terra di Lavoro”, il brigantaggio è stato, senza alcun dubbio, “un fenomeno di particolare complessità, per il notevole numero delle componenti che vi concorsero, e, perciò, non riconducibile entro schemi riduttivi e semplicistici”. L’immagine del brigante ha da sempre suscitato nell’immaginario collettivo, la figura, in un certo senso di “condottiero”, il quale diede sostegno alla causa legittimistica a vantaggio dei Borbone, rovesciati nel corso dell’unificazione nazionale (1861) dal trono delle Due Sicilie, e avversione alla causa unitaria, ovviamente, a svantaggio degli invasori piemontesi. Sempre secondo Olindo Isernia, lo stesso fenomeno brigantesco aprì la strada, in un certo senso, ad una “rivolta sociale e delinquenza comune, guerra civile e repressione militare”, come pure “occasione di vendette private e di violenza”, quest’ultima talvolta “efferata”. Di violenza davvero efferata ne parla lo stesso Isernia, tramite un episodio che si presentò davvero “agghiacciante”. I militi, giunti nel luogo dove venne trucidato un certo Francesco de Cesare, traditore, che era stato compagno di prigionia dei fratelli capibanda Giona e Cipriano della Gala, trovarono il corpo del de Cesare letteralmente mutilato: la testa decapitata con la pippa conficcata in bocca, le parti del corpo disseminate qua e la e ossa umane “spolpate”, il segno eloquente di un accanito cannibalismo. I militi presenti trovarono poi, un biglietto con su scritto “Così si fa coi traditori”. Ancora, tramite Olindo Isernia è possibile venire a conoscenza di un ulteriore episodio di efferatezza, questa volta a discapito di due sacerdoti di nome don Giacomo e don Pasquale Viscusi, che i briganti catturarono e trascinarono con loro in montagna, chiedendo poi alla famiglia un caro riscatto in denaro per la loro liberazione. I briganti, dopo aver ottenuta soltanto una parte del riscatto richiesto liberarono soltanto don Pasquale, trattenendo ancora presso di loro don Giacomo, e come monito, recidendogli nettamente l’orecchio, che poi, venne “assaggiato” da un componente della banda, il quale esclamò in dialetto: “Compa’, so bone le recchie dei Previti”. Il 15 agosto 1863, però, mentre nei territori meridionali imperversava il brigantaggio, venne emanata, dall’ormai governo sabaudo, la cosiddetta legge “Pica” che dettava precise disposizioni “dirette alla repressione del brigantaggio”. E’ oltremodo interessante, dai numerosi documenti conservati in molti archivi storici del meridione, venire a conoscenza di “notizie e curiosità su aspetti specifici della vita sociale e degli usi e costumi di una classe di individui o di singole persone”. Ad esempio, un dato del tutto curioso sugli aspetti di vita del brigante, appaiono in non pochi documenti relativi al modo di vestire di costui: “vestivano pressa a poco di giacca di panno colore oscuro, gilè due di essi rosso e tre oscuro, calzoni due oscuro, e due colore cecere e uno bigio, stivaletti di vitellino con molle e con sotto le suole le centrelle situate a due giri al contorno e nel vuoto”. La descrizione del “modo di fare” del brigante ci viene, però, fornita anche dai non pochi documenti d’archivio giunti fino ad oggi. E’ il caso, quest’ultimo del circondario di Piedimonte d’Alife (oggi Piedimonte Matese), dove il brigantaggio imperversò, trattandosi di una zona certamente più “isolata”, in modo certamente più acceso, mobilitando in maniera più attenta le autorità dell’epoca. Tra coloro che, senza se e senza ma, ritenevano di dover contrastare con ogni mezzo l’imperversare del brigantaggio, c’era proprio il sottoprefetto di Piedimonte d’Alife, il toscano Filippo Dainelli, il quale, nelle sue valutazioni descriveva il brigante come “nomade” e tendenzialmente a raggrupparsi in “banda”, aggirandosi anche da solo e, spesso, prendendo le sembianze “di onesto operante” senza tuttavia celare la personalità di “sanguinario assassino”. Il sottoprefetto Dainelli evidenziava, altresì che, il brigante, giustamente, preferiva dimorare in zone sicure come “le selve, le grotte e persino le siepi”. Per combattere il fenomeno brigantesco che fioriva sempre più nelle zone meridionali della Penisola, ancora sinceramente e in buona parte attaccate alla dinastia borbonica, il governo sabaudo pensò bene anche di affidarsi ad uno dei mezzi nascenti all’epoca, la fotografia, e questo non solo per fare propaganda, ma anche per cercare di incutere un certo timore. Capitava, infatti, che al momento di importanti arresti di capi briganti e della loro cerchia, questi, una volta letteralmente trucidati dai militari piemontesi, ripuliti i cadaveri, venivano messi “in posa” per la macabra occasione, collocati in posizione seduta con ai lati l’esecutore e, a volte, un sacerdote mentre gli puntava in volto le Sacre Scritture, per essere immortalati negli scatti del fotografo contattato per l’occasione. Tra i fotografi contattati dalle autorità piemontesi, un posto di rilievo lo ebbe il fotografo casertano Emanuele Giuseppe Russi che, una volta immortalati negli scatti i volti dei briganti catturati, di solito ne appuntava dietro la foto le loro generalità.
I. Gli “emarginati individui” di Casanova
In un rapporto redatto da Leonardo Tarantino, nella qualità di Delegato di Pubblica Sicurezza del Mandamento di Santa Maria Capua Vetere, in data 10 ottobre 1863, Il Prefetto di Terra di Lavoro veniva messo al corrente sulla condotta di tre uomini, “tutti di Casanova”. Si trattava di Michele Santoro fu Domenico, Alberto di Lucca fu Gaetano, Alessandro Menditto. Gli “emarginati individui”, attraverso le notizie raccolte venivano descritti “quali ladri, e pericolosi soggetti per la di loro pessima condotta passata, e presente”. Al momento della redazione del rapporto, il Delegato Tarantino, non poteva però raccontare del tutto i fatti che avevano coinvolto i tre uomini, in quanto “mancavano le fedi di perquisizione dé medesimi”. Ad ogni modo, il Tarantino assicurava che non appena le prove sarebbero giunte “da questo Tribunale e dalla Giudicatera Mandamentale”, queste sarebbero poi giunte al Prefetto, “in unione allo Elenco di tutti gli arrestati in questo Mandamento, in esecuzione della legge 15 agosto corrente”. Il risultato delle informazioni “più esatte”, però, giunse anche dalla Divisione dei Carabinieri Reali di Caserta, attraverso le quali fu possibile approfondire la condotta degli individui: Santoro Michele fu Domenico, di mestiere “contadino” e “d’anni 52”, di Lucca Alberto fu Gaetano “d’anni 56” e Menditto Alessandro fu Gaetano “d’anni 40”. Tutti “del Comune di Casanova”, gli individui erano “ritenuti sia da queste Autorità Locali che dalle persone probe” di pessima condotta “in linea di furti d’ogni genere”. Fino a quel momento, però, “Non si è(ra) potuto scoprire altro” perché nessuno voleva “particolarizzare per timore di confronti e per paura di vendetta”, certo, era senza smentita alcuna, concludeva il Comandante dei Carabinieri Reali, che erano “gente diffamate in ogni genere”.
II. Le informazioni raccolte su Alessandro Menditto
Assai interessante e ricca di particolari appariva la deposizione rilasciata da Anna Maria Manna, moglie di Alessandro Menditto, che la signora, appunto, rivolse al prefetto di Terra di Lavoro. La consorte del Menditto esordiva riferendosi alla violazione del “domicilio dé cittadini”, in quanto un episodio dovette turbarla particolarmente. Accadde, infatti, che nella notte del 3 ottobre 1863, un gruppo di Reali Carabinieri siccome giunsero per trarre in arresto il marito, irruppero nella casa della povera donna, la quale, però, si trovava da sola insieme “colle tre figlie zitelle”, mentre, il marito risultava assente “perché trova(va)si a travagliare in Napoli”. Il corpo dei carabinieri, quindi, presentatosi alla porta della signora Manna, senza neppure la presenza di un milite della Guardia Nazionale, non fece altro che spaventare le povere zitelle “col volersele portare con loro”. Giustamente, le povere ragazze “mandando fuori grida di spavento” e considerata la vicinanza con il posto di guardia della Guardia Nazionale, per prevenzione, “le legarono in casa”. Alessandro Menditto, però, a dire della moglie non doveva essere uno stinco di santo, perché nel 1848 “si tenne offesa la giustizia umana con semplice delitto”, dal quale ne uscì dopo aver scontato una giusta pena “di anni otto di reclusione”, finché poi giunse “il tempo di sue libertà” dove ebbe, in qualche modo, la possibilità di dimostrare la sua “ottima condotta”. La signora Manna, però, presa sicuramente dalla rabbia, inneggiava contro l’ormai passato governo borbonico, definendolo un periodo in cui “regnava il Dispotismo” e di conseguenze un governo “composto di Dispotici”. Sul conto di Alessandro Menditto, però, intervenne anche il parroco della chiesa di San Francesco di Paola in Caserta, nonché cappellano dell’ospedale militare ad essa accorpato, don Giovanni Cicatiello, il quale, tramite una nota del 13 novembre 1862, informava come, effettivamente, il Menditto fosse stato ammesso a lavorare presso l’ospedale militare nel 1849, “in qualità di secondo infermiere” e che, successivamente “fu licenziato alla fine del 1860”.
III. Michele Santoro “imprigionato per semplice sospetto”
Non di rado le autorità dell’epoca, prese dalla foia di estirpare il fenomeno brigantesco, suscitato dalla causa legittimista borbonica, tendevano a fare “di tutta un’erba un fascio”. Capitava, infatti, che negli arresti cadessero vittime anche persone effettivamente innocenti le quali, al minimo segnale, venivano additate come ancora legati al re Borbone, sua maestà Francesco II. Una situazione del tutto simile, si verificò ai danni di Michele Santoro che, una volta arrestato venne “imprigionato per semplice sospetto di ancora corrispondenza con banda armata”. Il responsabile della pubblica sicurezza che compilò il rapporto nei confronti del Santoro, diceva che, in realtà, una volta che ebbe modo di esaminare “la sua coscienza”, si rese conto che egli era “immune di si nera imputazione” nonostante avesse subite “vendette private; per inimicizie, ed anche per antipatia”, venne tuttavia “innocentemente ed inumanamente imprigionato”. L’analisi, per così dire psicologica del Santoro, continuò facendo fuoriuscire il lato buono dell’individuo, perché egli aveva sempre vissuto “da onesto e religioso cittadino, badando solo ai lavori campestri per sostentare la sua famiglia”. A convalidare le citate affermazioni raccolte dalle autorità competenti, erano stati anche quegli “attestati di buona e regolare condotta” rilasciati dal parroco di Coccagna don Francesco Fiano e dalle autorità municipali “della sua Patria”. In modo particolare, il parroco don Francesco Fiano evidenziava, sul conto del Santoro che in quegli ultimi anni “nella sua vita pubblica ha(veva) mostrata una buona condotta morale, e per alimentare se e la sua piccola famiglia si è(ra) occupato nel suo negoziato di calce”. Michele Santoro, quindi, poteva considerarsi a tutti gli effetti vittima di “mala giustizia”, perché “senza ombra di reato e senza trasgressione” delle leggi vigenti all’epoca, per questo motivo poteva ritenersi innocente. Il Santoro, però, chiedeva al prefetto di Caserta che, qualora le attestazioni positive rivoltegli non fossero state soddisfacenti “a farlo porre in libertà per attendere alle faccende campestri” dato che si raccoglievano “i generi autunnali” ed era pure il periodo della vendemmia, le autorità avessero fatto comunque il loro corso attraverso “altre investigazioni” sulla sua condotta, provando definitivamente che si trattava certamente di calunnie e di vendetta privata, cioè quelle cose che a dire del relatore dovevano “non solo tacere e scomparire, ma eliminarsi nell’attuale regime liberale” e specialmente in quel momento storico assai delicato di “transizione”, in cui il prefetto “regola(va) così bene i destini di questa Provincia”. Tuttavia, però, il Santoro, probabilmente per mera prevenzione venne mandato a “domicilio coatto”, così come risultava dalla nota appuntata sul fascicolo riguardante i tre “casanovari”.
IV. La situazione di precarietà familiare di Alberto Di Lucca
A pagare le conseguenze della rappresaglia piemontese nei confronti dei briganti o presunti tali erano, come già detto, anche persone effettivamente per bene. Alberto Di Lucca oltre a dover vivere una situazione psicologicamente difficile, perché si trovava in carcere a Santa Maria Capua Vetere nell’ottobre 1863, faceva trapelare tuttavia, la sua preoccupazione per la famiglia. Il Di Lucca si trovava in carcere per semplice sospetto “senza che finora non ha(vesse) commettuto qualche furto” come in realtà sosteneva il prefetto di Caserta. La numerosa famiglia di Alberto Di Lucca era composta dai “suoi figli di basetà” , i quali, giustamente domandavano pietà, almeno “per il vitto giornaliero che il padre medesimo gli offriva” così da “non perire di fame”. Anche la Giunta comunale di Casanova guidata dal sindaco Crescenzo Castiello, e rappresentata dai consiglieri: Giuseppe Mingione, Michele Cipriano, Giuseppe Mingione, Francesco Perrotta, Pasquale Tescione e dal parroco di Santa Croce don Giovanni Natale, segnalavano del Di Lucca che, domiciliato nel medesimo Comune, era di condizione “colono” ed era, allo stesso tempo “di buona e regolare condotta”, non avendo mai dato nel pubblico, “alcun motivo di doglianza, sul suo conto”. Oltre agli attestati di buona condotta, certamente, ciò che dovette far “intenerire” le autorità, fu la situazione familiare a causa dell’assenza del padre, e per questo il Di Lucca venne “liberato”, come risultava dalla nota appuntata sul fascicolo dei tre “casanovari”.
Fonti
- Archivio di Stato di Caserta, Prefettura – affari diversi – polizia, busta 169 – fascicolo 46.
- Loretta De Felice (a cura di), Fonti per la storia del brigantaggio postunitario conservate nell’Archivio Centrale dello Stato: tribunali militari straordinari, Salerno 1998.
- Olindo Isernia, Nuovi saggi di storia casertana: Ottocento – Novecento, Caserta 2006.
- Olindo Isernia, Terra di Lavoro e la sua storia: dodici contributi, Caserta 2010.
- Olindo Isernia, Per una lettura ravvicinata del brigantaggio postunitario in Terra di Lavoro, Caserta 2011.